Bari. Croci, arcate e decori policromi: alla scoperta del millenario ipogeo di via Martinez
Letto: 5091 volte
giovedì 17 aprile 2025
Letto: 5091 volte
di Giancarlo Liuzzi - foto Paola Grimaldi
Ci sono però delle eccezioni. Tra queste l’ipogeo di via Martinez: un luogo all’interno del quale è ancora possibile riconoscere l’originaria e affascinante architettura fatta di nicchie con giacigli scolpiti nella roccia, croci incise sui pilastri, suggestive arcate e sorprendenti decori policromi.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Siamo così andati a visitare questo sito millenario che si trova nella località denominata “la Grava”, scavato tra l’VIII e l’XI secolo nel banco roccioso di Lama Fitta. (Vedi foto galleria)
Per raggiungerlo percorriamo corso Alcide De Gasperi in direzione Carbonara per svoltare poi a sinistra su strada Terzo Scambio. Superato il circolo Tennis imbocchiamo via Martinez. Qui costeggiamo un complesso di villette per ritrovarci dopo pochi metri in aperta campagna. Sulla nostra sinistra si apre infatti la depressione di Lama Fitta occupata da un terreno con un vigneto.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Scendendo nel campo incrociamo subito sulla nostra sinistra la bocca di un’antica cisterna in pietra ormai priva di acqua ma piena di sporcizia. Alla nostra destra invece, nascosti da edera e vegetazione, si celano gli ingressi dell’ipogeo.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Il complesso si estende su 220 metri quadri (allungandosi anche sotto la strada adiacente) e comprende una chiesa, una grande camera centrale e altri ambienti più piccoli che costituivano i magazzini e luoghi di riposo della comunità qui presente. L’accesso a questi locali, introdotto da un albero di fico, si trova sul fianco occidentale.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Prima di accedere veniamo a conoscenza, grazie agli scritti degli studiosi Franco e Carlo dell’Aquila, che il sito viene anche chiamato “dei Romiti”, termine che dovrebbe far riferimento ai monaci eremiti che lo scavarono tra l’VIII e l’XI secolo (con ampliamenti nei secoli successivi) con funzione religiosa e abitativa.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Luogo che faceva parte di un più ampio casale denominato Cillaro: un agglomerato rurale composto da più costruzioni e insediamenti abitativi e agricoli e il cui fulcro erano le chiese e gli ambienti religiosi. Questi si trovavano proprio negli ipogei. A poca distanza da qui sono infatti presenti altre strutture sotterranee, quali quella della Grava, di Villa Lopez, del Casino Stevanato e di Masseria La Vela.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Non ci resta ora che entrare. Ci ritroviamo subito in un ambiente, in parte ricolmo di pietre e terreno, che mostra un soffitto piano sul quale sono riconoscibili fossili di conchiglie e dei ganci utilizzati in passato per appendere delle lucerne.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Un varco ci conduce a un secondo vano che, a destra, porta a un ulteriore locale forse destinato ad attività lavorative. Qui troviamo dei pali in ferro arrugginiti che sorreggono la volta, danneggiata nel 2005 a seguito di alcuni lavori stradali che portarono a un crollo di parte della grotta. L’intervento della Soprintendenza fermò i lavori e fu chiesto al Comune di Bari di presentare un progetto di recupero e valorizzazione dell’intero ipogeo. Niente di tutto questo fu però mai fatto.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Proseguiamo. A sinistra raggiungiamo il locale più ampio: un vano di circa 40 metri quadri per metà interrato, illuminato dalla poca luce che proviene dall’esterno. Il soffitto è retto da grossi pilastri dove sono riconoscibili delle croci incise nella pietra e una griglia forse utilizzata come calendario delle attività rurali, che riporta la data del 1781.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Sulle pareti laterali vi sono poi piccoli locali che ospitano diverse nicchie di varie dimensioni: alcune usate per sorreggere dei lumi e altre, più ampie, adibite a giaciglio. In una di queste è ben visibile anche il rialzo della pietra usato come cuscino.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Torniamo in superficie per spostarci verso l’ingresso del tempio religioso, che si trova a pochi metri di distanza. Si tratta della chiesa di San Leo(ne), costruita in epoca bizantina da un sacerdote di nome Leo che la lasciò in eredità, nel 1089, al presbitero Mele. Il luogo di culto rimase sotto la giurisdizione del duomo di Bari tra il XV e il XVI secolo, per poi essere concesso ad altri abati che lo curarono nel corso del tempo. Fino a quando la chiesa fu pian piano abbandonata per essere parzialmente interrata alla fine dell’XIX secolo.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
L’originario accesso, costituito da un portale a sezione rettangolare, è ormai occluso da vegetazione e pietrame. Ci facciamo quindi strada attraverso un piccolo varco circolare, forse l’apertura di un’antica finestra.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Siamo dentro (vedi video). La struttura, di circa 45 metri quadri, è composta da due zone distinte frutto di un raddoppio dell’originario luogo di culto.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Il primo vano si presenta con due navate asimmetriche, divise da una serie di suggestive arcate che si susseguono, con andamento est-ovest e con una leggera apertura a ventaglio, verso l’area presbiteriale. Su tutte le pareti vi sono delle nicchie aniconiche, cioè prive di decorazioni, simili a quelle presenti nella basilica rupestre di Santa Candida di Lama Picone.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
La zona presbiteriale, leggermente rialzata dal resto dell’ambiente, è limitata dal muretto dell’iconostasi che divide la parte del naos (dove si riunivano i fedeli) da quella del bema, destinata al rito religioso. Quest’ultima era delimitata da quattro colonne con capitelli cubici, tre delle quali rimosse o crollate, che davano l’idea di un ciborio che si estendeva su tutta l’area.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Al centro della zona absidale doveva esserci un altare alla greca, oggi assente, mentre sul fondo del catino absidale notiamo un varco di accesso a una tomba scavata nella pietra. Alzando lo sguardo, coperti appena da uno strato di polvere, ci sorprendiamo nell’individuare, sulla doppia ghiera dell’arcata superiore, alcune tracce superstiti di affreschi che, probabilmente, adornavano buona parte dell’intero presbiterio.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Riconosciamo dei motivi a rombi ocra e rossi e dei decori geometrici più scuri con alcune croci. Ma non sono gli unici affreschi presenti nell’ambiente. Simili decorazioni le troviamo su quasi tutte le arcate, poste in direzione del naos, in modo da poter essere viste dai fedeli.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Ci spostiamo infine nell’abside laterale, utilizzata in passato come diakonikon: zona delle chiese bizantine destinata a sagrestia. Sul fondo del catino absidale è presente un pozzetto, mentre più in alto è ben riconoscibile una grande croce scolpita nella pietra.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Anche qui l’arcata superiore è finemente decorata con un motivo geometrico a fascia dai toni rosso e blu. Al centro delle figure vi sono anche alcune croci, triangoli e vari cerchi a carattere simbolico. Ulteriori testimoni del passato religioso del suggestivo ma dimenticato ipogeo di via Martinez.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
(Vedi galleria fotografica)
Nel video (di Paola Grimaldi e Gaia Agnelli) la nostra visita all’ipogeo “dei Romiti”:
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita


















.jpg)


.jpg)
.jpg)





.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)








.jpg)
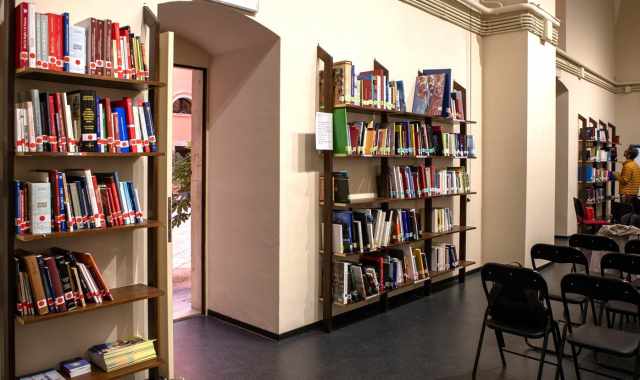
-copertina.jpg)

