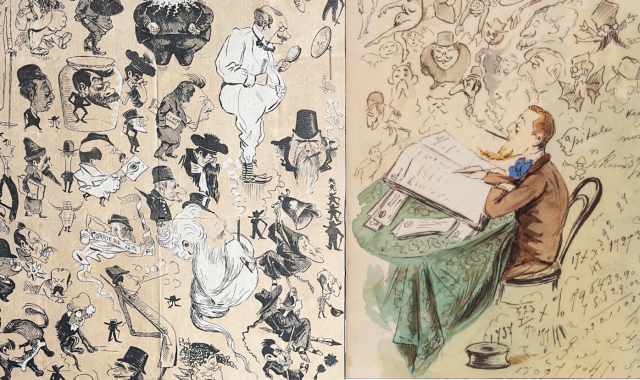La storia e le opere di Niccolò dell'Arca: il grande scultore dimenticato dalla "sua" Bari
Letto: 4630 volte
venerdì 17 ottobre 2025
Letto: 4630 volte
di Raniero Pirlo
Tuttavia, nonostante sia stato uno dei più innovativi artisti del XV secolo, noto soprattutto per la sua capacità di esprimere drammaticità, emozione e realismo nelle sue sculture, dell’Arca a Bari è poco celebrato. Il motivo è solo uno: la sua carriera si svolse lontano dalla terra natia.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Fu infatti a Bologna, dove si trasferì nel 1460, che la sua arte raggiunse l’apice. In Emilia realizzò tutti i suoi capolavori: dal Compianto sul Cristo morto all’Arca di San Domenico, opera quest’ultima che gli valse il soprannome con cui ancora oggi è conosciuto.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Poche sono le notizie biografiche su di lui, a partire dalla sua incerta data di nascita che viene collocata dagli studiosi tra il 1435 e il 1440. Riguardo alle sue origini geografiche, anche queste sono avvolte da un certo mistero. Se alcuni ipotizzano la sua nascita in Dalmazia, la maggioranza degli studiosi concorda sulle sue radici pugliesi.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Di certo fu nel tacco d’Italia che visse la giovinezza, come testimoniato dai documenti che lo citano come “Nicolaus de Apulia”: un appellativo che egli stesso utilizzò per firmare alcune sue opere. In particolare proprio Bari sarebbe stata la sua casa. Infatti, stando a quanto raccontato dallo storico bolognese Leandro Alberti, un biglietto posto all’interno dell’Arca di San Domenico che nominava tutti gli artisti che avevano contribuito all’opera, menziona lo scultore come “Nicolaum Barrensem”, ossia Niccolò di Bari.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Il capoluogo pugliese avrebbe quindi dato i natali o perlomeno “cresciuto” «colui che dava vita alle pietre e creava statue viventi», come recita l’epitaffio della lapide sepolcrale dell’artista. Niccolò dell’Arca viene infatti considerato tra i più importanti scultori del XV secolo. Le sue opere, animate da un potente realismo e da una grande espressività, continuano ancora oggi a trasmettere una forte emozione all’osservatore.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Per ammirarle dobbiamo recarci come detto a Bologna. (Vedi foto galleria)
Arrivati nella città delle due torri, ci dirigiamo subito verso il centro, precisamente in Piazza Maggiore. Da qui imbocchiamo la frequentata via d’Azeglio, celebre per aver ospitato la casa di Lucio Dalla. A pochi passi dal balcone del cantautore, il nostro sguardo viene catturato da una targa commemorativa dedicata proprio a dell’Arca.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Situata in alto, tra i civici 15 e 17 della strada, la lastra si trova sulla parete esterna della chiesa di San Giovanni dei Celestini, lì dove un tempo erano conservati i resti dell'artista, in seguito spostati nel cimitero di Bologna.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Ciò che è scritto ci conferma le sue origini baresi: «Nicolò scultore dalmata di origine nato in Bari di Puglia dall’Arca di San Domenico in Bologna ebbe il nome e la gloria. Morì l’anno 1494 e fu sepolto in questa Chiesa dei Celestini».Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Inoltre sotto questa iscrizione leggiamo anche la predetta epigrafe latina che fu posta sulla sua lapide. Questa la traduzione: «Colui che dava vita alle pietre e formava con il cesello statue viventi, che dolore! È sepolto qui. Ora Prassitele, Fidia, Policleto venerano e ammirano le tue opere, o Nicola».Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Tornati in Piazza Maggiore imbocchiamo via Clavature. Al civico 10 ci troviamo davanti al Santuario di Santa Maria della Vita, che custodisce al suo interno uno dei capolavori dell’artista: il Compianto sul Cristo Morto.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Entriamo nella chiesa e raggiungiamo l’opera esposta alla destra dell’altare. Essa rappresenta il drammatico momento che segue la deposizione di Cristo dalla croce, poco prima della sua sepoltura. Davanti a noi si dispongono sette figure a grandezza naturale, modellate in terracotta con straordinaria intensità.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Al centro giace il corpo di Cristo, disteso con il capo reclinato su un cuscino. Attorno a lui, sei personaggi immersi nel dolore partecipano al lutto con gesti e posture differenti, ognuno espressione di un sentimento unico di disperazione.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Sulla sinistra Giuseppe d’Arimatea, discepolo di Gesù, volge lo sguardo verso l’osservatore, quasi a coinvolgerlo nella scena. Maria, la madre, è ritratta con il volto sfigurato dal profondo dolore. Particolarmente toccanti sono anche le figure di Maria di Cleofa e Maria Maddalena, le cui vesti, aderenti ai corpi, volano come mosse da un impeto di dolore, catturando il momento dell’urlo e dell’angoscia.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Proprio per il realismo della scultura di Maria Maddalena, il poeta Gabriele d’Annunzio celebrò l’opera e la definì efficacemente l’«urlo di pietra».Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Prima di andar via notiamo un’incisione sul cuscino del Cristo: leggendo il cartello descrittivo scopriamo che si tratta della firma dell’artista, che ancora una volta ricorda le proprie origini. Vi è scritto: «Opus Nicolai de Apulia».Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Ancora profondamente colpiti dall’intensità di queste sculture, usciamo per proseguire verso l’ultima tappa. Lasciamo la zona più turistica e ci dirigiamo a sud del centro storico, verso Piazza San Domenico. Proprio qui, nella basilica patriarcale di San Domenico Gùzman, c’è l’Arca che diede il nome allo scultore barese.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
L’opera non è altro che la tomba dove sono custodie le ossa di San Domenico, un grande sepolcro marmoreo sul quale Niccolò di Puglia lavorò dal 1469 al 1473.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
La troviamo in una maestosa cappella all’interno della chiesa, sulla destra rispetto alla navata centrale. Ad accoglierci c’è un cartello descrittivo che nomina tutti gli artisti che lavorarono nel corso degli anni all’arca, fra i quali anche Michelangelo Buonarroti. Ci racconta che lo scultore barese si occupò della parte superiore dell’arca, detta cimasa: «Tutta la cimasa è opera mirabile di Niccolò di Antonio da Bari, universalmente conosciuto come Niccolò dell’Arca, dal nome di questo che è il suo capolavoro».Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Superiamo un cancello e ci avviciniamo all’imponente sarcofago marmoreo, decorato con numerose figure scolpite che sembrano prendere vita davanti a noi. Ci concentriamo sulla parte superiore della tomba, quella realizzata da Niccolò.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
In alto si distingue Dio Padre, che tiene nella mano sinistra il mondo, vicino al cuore. Poco più sotto compare un secondo globo, più grande, accompagnato dai simboli della creazione. Scendendo con lo sguardo, osserviamo la scena del mistero della Redenzione: Gesù morto è affiancato da due angeli (a destra quello dell’Annunciazione, a sinistra quello della Passione) e circondato dai quattro evangelisti. Nella parte inferiore della cimasa si trovano infine otto statue, disposte lungo il bordo dell’arca, che raffigurano i santi protettori di Bologna.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Anche qui colpiscono la vitalità e l’intensità emotiva dei personaggi scolpiti. Le figure marmoree dei santi, modellate con grande precisione e padronanza, appaiono eleganti e piene di movimento, celebrando così la vita di San Domenico e il genio di Niccolò dell’Arca, il “Barrensem”.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
(Vedi galleria fotografica)
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita
I commenti
- antonio arky - certo che vedere il Compianto è un godimento dello spirito come di tutti i sensi, essendo stato dipinto e avendone perso i colori restano evidenti le impronte dell'autore e delle maestranze tutte, veder così plasmare la materia rende ancora più viva la stessa, invito chiunque venga a Bologna a visitare la Chiesa di Santa Maria della Vita dalle antiche meste origini che conserva anche altre Grandi Sorprese. Davvero!


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




.jpg)
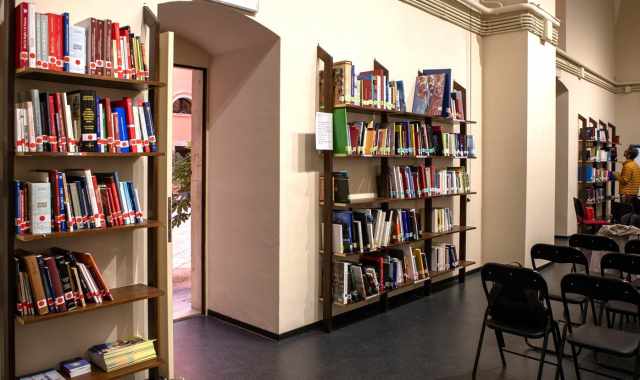
-copertina.jpg)



.jpg)