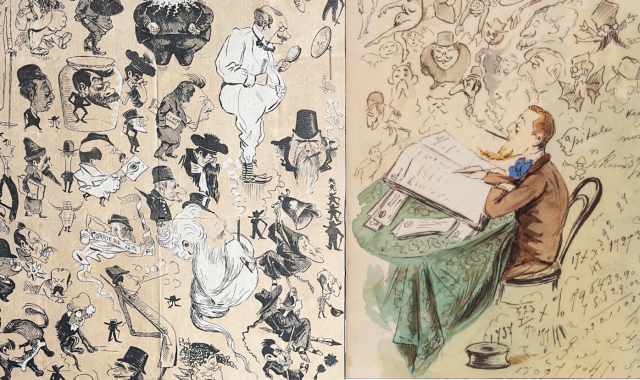Fotografia, l'ottocentesca tecnica del collodio: «Così si rivela la natura di un corpo»
Letto: 14212 volte
venerdì 20 maggio 2016
Letto: 14212 volte
di Katia Moro
Questa tecnica fu inventata nel 1851 dal britannico Frederick Scott Archer, che per primo scoprì che il collodio (una miscela di nitrocellulosa, alcol e etere con all'interno disciolti dei sali) non solo aderiva al vetro, ma dopo un'immersione di qualche minuto nel nitrato d'argento, lo rendeva anche fotosensibile e quindi capace di reagire all’esposizione alla luce regalando magicamente le immagini fotografate.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Il risultato sono delle immagini molto diverse da quelle a cui siamo abituati. Emergono volti più duri quasi privi di espressione ma veri ed essenziali, che appaiono atemporali. Anche gli oggetti acquisiscono il fascino dell’epoca indefinibile e sembrano perdere ogni connotazione spazio-temporale anche a causa della particolare colorazione dovuta al materiale di supporto metallico o vitreo. Al contrario delle foto digitali queste immagini non sono mai perfette ma presentano macchie, striature e sfocature che le rendono però particolari e inconsuete.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
«D’altronde i tempi di esposizione sono molto molto più lunghi – spiega De Napoli -. Io oggi riesco a ridurre la “posa” anche a 30 secondi, in buone condizioni di luce, ma è chiaro che nessuno riesce a rimanere in una postura forzata e innaturale per così tanto tempo e così ne emerge un ritratto che rivela la vera natura di un volto o di un corpo».Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Francesco è uno dei pochi a utilizzare questa tecnica in Italia, che invece ha ritrovato molti estimatori in Germania, Olanda e Stati Uniti. Il fotografo in questo caso deve occuparsi di ogni fase della realizzazione, dalla preparazione sino alla resa finale. Armato anche di maschera per gas, polveri e vapori, guanti e occhiali da protezione, data l’alta tossicità dei sali disciolti all’interno, come il cadmio e il cianuro di potassio usato per il fissaggio e a causa della pericolosità dei nitrati d’argento che, entrando a contatto con gli occhi, possono provocare cecità.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
De Napoli ci spiega come agisce. «Si inizia con la preparazione della lastra di vetro pulita con carbonato di calcio, alcol e acqua distillata – descrive -. Si stende poi sui bordi un leggero velo d’albume d’uovo e poi si versa su il collodio. Una volta formatasi la cosiddetta “pelle”, si immerge il supporto per tre minuti nel nitrato d'argento e lo si inserisce in uno chassis, il porta lastre che si trova all’interno delle vecchie macchine fotografiche. Tolto il tappo dall'obiettivo, si espone la lastra alla luce per il tempo necessario e si scatta la foto. A questo punto si passa allo sviluppo, al fissaggio e infine alla verniciatura con gomma sandracca necessaria a garantire una conservazione più duratura».Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
La fase che intercorre dal momento dell’esposizione a quella dello sviluppo non deve superare l’arco temporale dei 10 minuti, perché altrimenti il collodio diventerebbe meno sensibile. Ciò rende necessario avere sempre una camera oscura nell’immediata vicinanza della zona in cui la fotografia viene scattata. Ed è per questo motivo che i paesaggisti del passato usavano carrozze con cavalli sui quali facevano trainare le loro camere oscure portatili. Anche oggi alcuni fotografi si sono attrezzati con camper o biciclette adibiti alla stessa funzione.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Ma perché ritornare indietro di secoli per produrre una fotografia? «Anche io sono pienamente calato nell’epoca della fotografia digitale e del “post” su Facebook – ci risponde Francesco -. Ma ho sentito a un certo punto l’esigenza di arrestare questo flusso troppo veloce e spesso superficiale, per tornare ad assaporare la lentezza ponderata e misurata dei vecchi artigiani». Perché per andare avanti, a volte, è necessario guardarsi indietro.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
(Vedi galleria fotografica)
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita
Scritto da
Katia Moro
Katia Moro








.jpg)