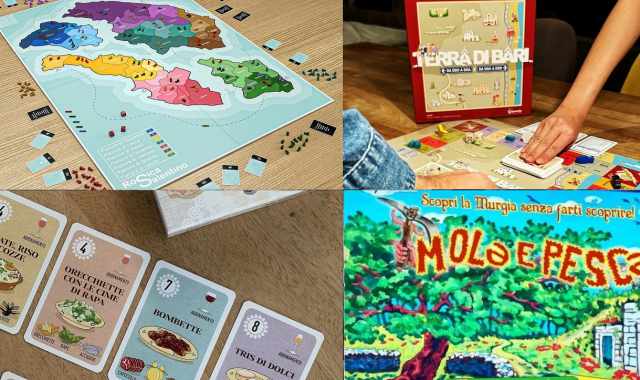Incontri segreti, processi e statue "riparatrici": quando Santo Spirito era base di massoni e carbonari
Letto: 2081 volte
giovedì 11 settembre 2025
Letto: 2081 volte
di Francesco Sblendorio
Già da inizio XIX secolo in molti Comuni del Nord Barese (da Barletta a Molfetta, passando per Modugno e Grumo) erano attive organizzazione segrete come Massoneria e Carboneria, i cui affiliati provenivano quasi sempre dalle classi sociali progressiste. Solo nella vicina Bitonto (Santo Spirito era la “marina” del paese) si contavano quasi 400 membri.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Non è un caso che, tra i motivi che spinsero la curia locale a volere la costruzione della chiesa di Santo Spirito, vi fu anche la necessità di riavvicinare alla pratica cristiana una comunità fin troppo attraversata da simpatie anticattoliche.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Come avrebbe rilevato a fine secolo il parroco don Vito Antonio Vacca, nell’800 «molti nativi del villaggio erano inquinati dagli errori della Massoneria, quindi atei». Tra il 1843 e il 1852 vide quindi la luce la chiesa dello Spirito Santo (ancora oggi attiva), edificata su un terreno acquistato, ironia della sorte, dagli eredi di un massone: Teodoro Saracino.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
La scelta dei cospiratori di riunirsi a Santo Spirito fu quindi quasi inevitabile: si trattava di una località facilmente raggiungibile dai paesi vicini e soprattutto ricca di residenze private di facoltose famiglie borghesi. L’incontro clandestino avvenne proprio in una di esse: Villa Cioffrese, tutt’ora esistente su via Napoli anche se disabitata e nascosta da edifici moderni.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
La notte tra il 20 e il 21 giugno 1848 si svolse così questo summit segreto di liberali antiborbonici organizzato dal conte bitontino Giovanni De Ildaris. A fare gli onori di casa fu Marco Cioffrese, che aprì le porte della sua dimora agli oppositori del governo.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
I convenuti a casa Cioffrese erano massoni e carbonari arrivati da tutto il Nord Barese. Va detto che Massoneria e Carboneria avevano a livello nazionale profili diversi. La prima era tendenzialmente francofila, anticattolica e si riuniva in “logge”. La seconda, nata dalla prima, era antifrancese al Sud Italia, meno anticlericale e organizzata in “vendite”. A livello locale però le differenze si sfumavano.
Lo stesso Marco Cioffrese, borghese esponente della massoneria, era figlio di Pasquale, carbonaro ai tempi dei moti antiborbonici del 1821, oltre a essere nipote di Marco “seniore”, impegnato nella Repubblica Partenopea del 1799.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
L’incontro segreto rappresentò una delle svariate forme di ribellione diffuse in tutto il Meridione alla repressione messa in atto da Ferdinando II il 15 maggio precedente. Dopo aver concesso la Costituzione, infatti, il re di Napoli aveva soffocato nel sangue le proteste dei liberali partenopei che chiedevano modifiche allo Statuto.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Quel convegno di due giorni fu fruttuoso. Si decise infatti di indire per il 2 e 3 luglio la “Dieta di Bari”: una nuova riunione di oppositori che avrebbe posto le basi per la composizione di un governo provvisorio atto a gestire la transizione dall’assolutismo borbonico a un sistema liberale.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Un incontro quest’ultimo che avvenne, ma che portò a conseguenze terribili per i ribelli. Ad agosto infatti le truppe di Ferdinando II occuparono Bari e arrestarono alcuni rivoltosi, mentre sulla riunione di Santo Spirito si aprì un processo.
«Riunione illecita con vincolo di segreto ed eccitamento alla guerra civile»: questa l’accusa con cui 22 persone vennero imputate. L’episodio allarmò non poco le autorità del Regno, viste le dimensioni del procedimento giudiziario istruito dalla Gran Corte Criminale. Basti dire che tra il 1850 e il 1852 furono chiamati a deporre 435 tra testimoni, periti e imputati e vennero redatti 919 fogli di atti processuali.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Tra i testimoni, molti erano abitanti di Santo Spirito, gente umile e disinteressata alle questioni politiche. Pescatori, contadini, tavernieri, osti, caffettieri, panettieri e cocchieri vennero interrogati talvolta anche con durezza.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Nella prima fase però quasi tutti si mostrarono reticenti a fornire informazioni. Una scelta che indusse il giudice a disporre per diversi di loro la segregazione in carcere, in modo da ottenere un cambio di atteggiamento nelle fasi successive del processo. Cosa che avvenne, visto che i santospiritesi furono più disponibili a raccontare quel che avevano notato.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Alla fine non si riuscì a delineare un quadro completo dell’accaduto, ma ci furono alcune condanne. Cioffrese ad esempio non sfuggì alla giustizia: nel 1851 fu arrestato e rinchiuso in carcere.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Ma a questo punto della storia, a sorpresa, ci fu l’intervento della Chiesa. La Curia, storica “nemica” dei massoni, si prodigò per aiutarli, forse in cambio di una di un’apparente “conversione”.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Il vescovo Nicola Marone, ad esempio, si spese per De Ildaris, che infatti non andò in prigione subendo solo l’esilio a Foggia. Allo stesso modo non è da escludere che qualche alto prelato sia intervenuto anche a favore di Cioffrese, dato che questi uscì dal carcere nel 1860 e, una volta libero, come primo gesto simbolico commissionò una statua in legno della Madonna Immacolata.
Scultura "riparatrice" che fece conservare in un’altra residenza di famiglia: Villa D’Amelj Melodia, situata sempre su via Napoli e con cappella accessibile per tutto il popolo dal lungomare. Cioffrese donò la scultura alla comunità di marinai del borgo, i quali inaugurarono la tradizione di portare in processione l’Immacolata partendo proprio dalla scogliera nei pressi della cappella.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
E oggi, nonostante la statua sia stata spostata nella chiesa principale da oltre un secolo, i pescatori usano ancora portarla in processione e vegliarla a bordo di un peschereccio in occasione della festa patronale di agosto. Con buona pace della massoneria.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
(Vedi galleria fotografica)
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita

.jpg)

.jpg)
.jpg)












.jpg)